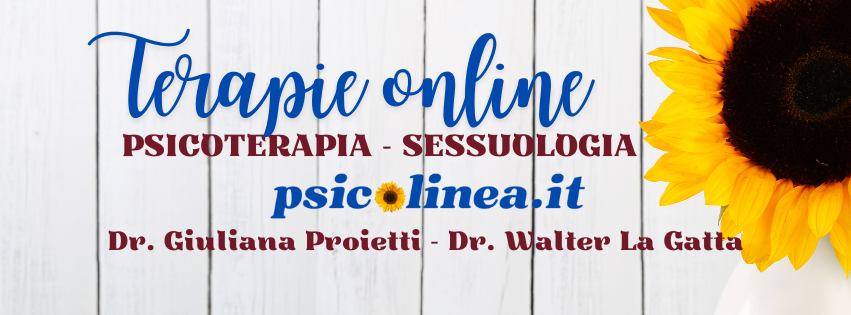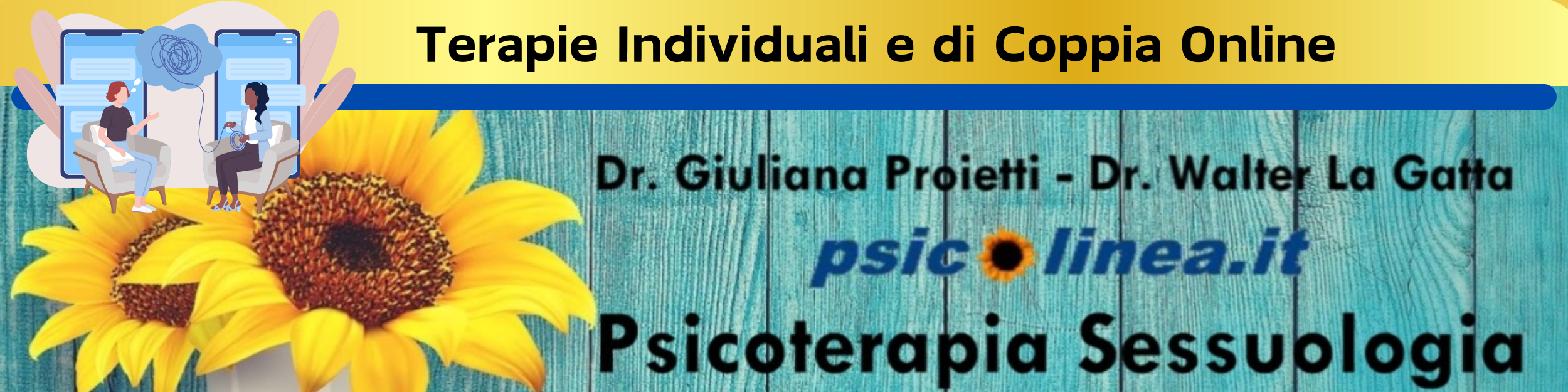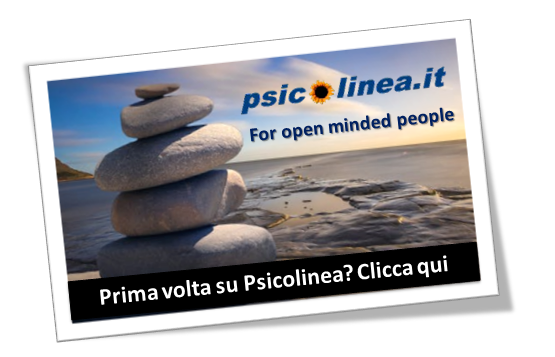La pubertà preoce: un male o un bene? Cosa si intende per pubertà precoce? La tipica pubertà...
Infanzia e Adolescenza
Infanzia e Adolescenza – PSICOLINEA
Con questo Tag di Psicolinea pubblichiamo articoli divulgativi su tematiche relative all’età evolutiva: infanzia e adolescenza.
Terapeuti di Psicolinea:
Dr. Giuliana Proietti - Tel. 347 0375949
Dr. Walter La Gatta - Tel. 348 3314908
Se i genitori sono anziani In Italia l’età media delle donne al momento della nascita del primo...
Il disagio di avere i genitori separati Cosa comporta una separazione o un divorzio per una famiglia?...
Adolescenti stressati per il poco sonno L’adolescenza è una fase di passaggio all’età adulta che porta con...
Adolescenti e autolesionismo Cosa è l’autolesionismo? L’autolesionismo è un danno inflitto a se stessi in maniera intenzionale....