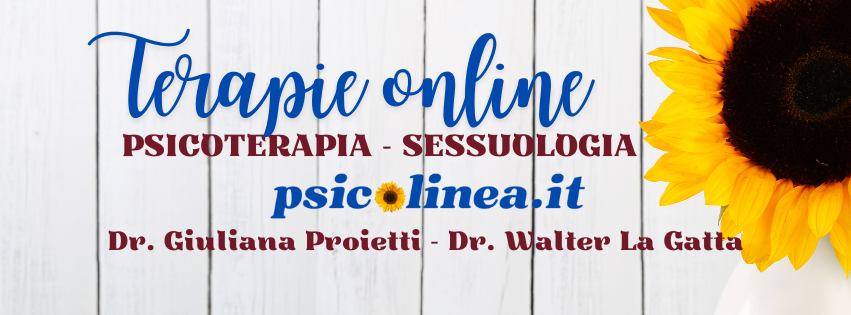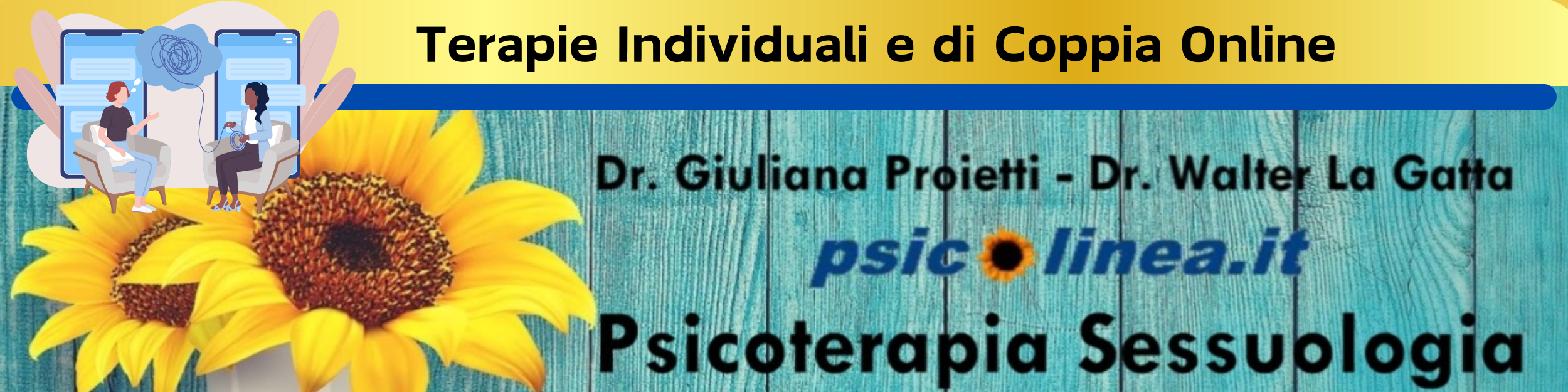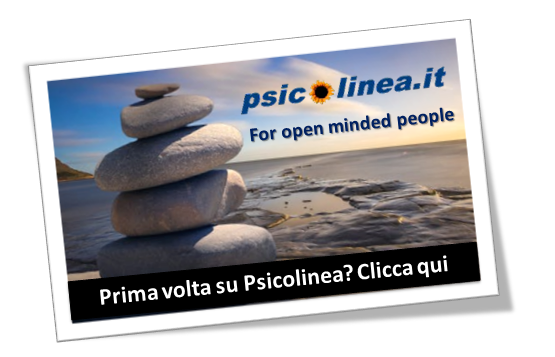Gli effetti psicologici dell’acne L’acne, spesso considerata solo come un problema estetico, può avere un impatto significativo...
Salute e Malattie
Salute e Malattie – PSICOLINEA
In questa Categoria di Psicolinea pubblichiamo articoli divulgativi sui temi della salute e della malattia.
Terapeuti di Psicolinea:
Dr. Giuliana Proietti - Tel. 347 0375949
Dr. Walter La Gatta - Tel. 348 3314908
Costo della Terapia online, Individuale e di Coppia, 70 euro
Attacchi di panico: eziologia, sintomatologia e trattamento Gli attacchi di panico rappresentano un disturbo psicologico debilitante caratterizzato...
Il disturbo ossessivo-compulsivo (e test di automonitoraggio) Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) è un disturbo psicologico caratterizzato da...
Cleptomania: il bisogno patologico di rubare Cosa significa cleptomania? La cleptomania indica un bisogno patologico di rubare,...
L’autismo altamente funzionale In passato solo le persone con sintomi molto gravi venivano diagnosticate con autismo, ma a partire...