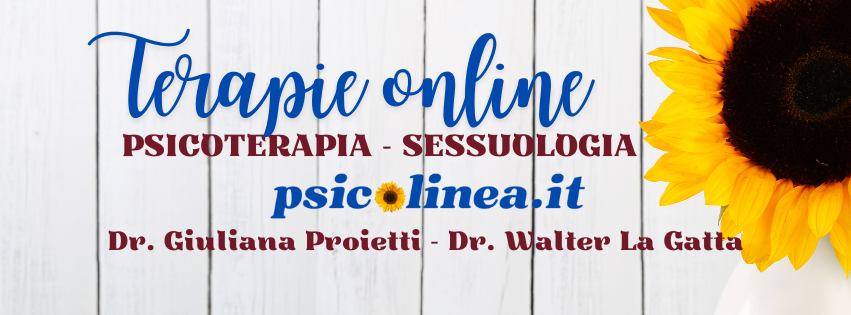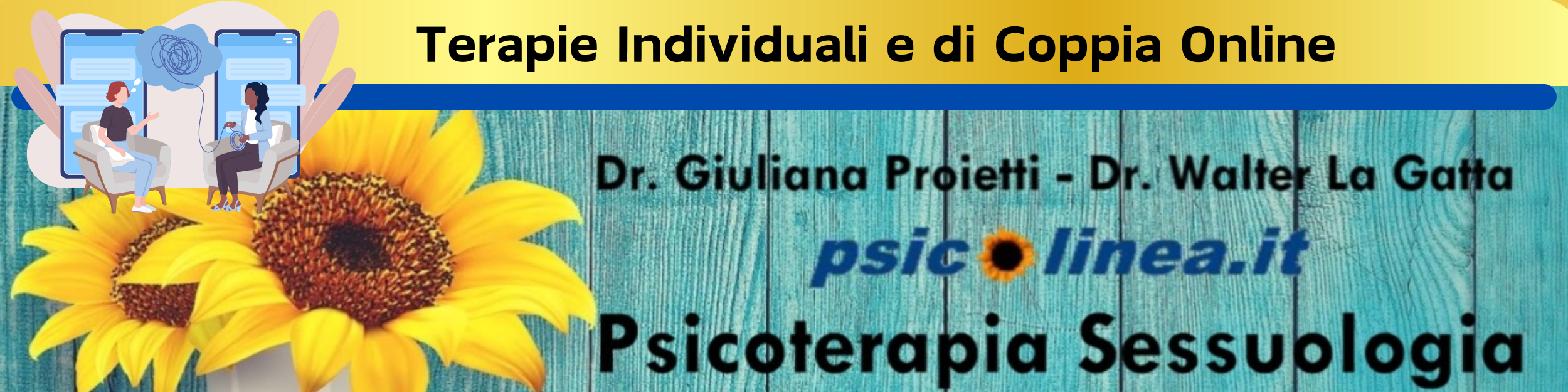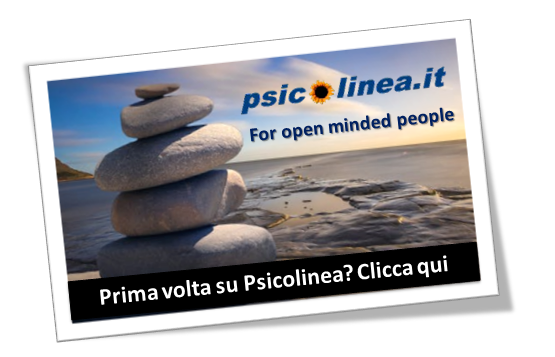Storia dell’ipnosi 1: Mesmer e il magnetismo animale Nel XVIII secolo, un medico austriaco di nome Franz...
Psicologia
Psicologia– PSICOLINEA
In questa Categoria di Psicolinea pubblichiamo articoli divulgativi su vari argomenti di psicologia, dando informazioni pratiche, con linguaggio non specialistico.
Terapeuti di Psicolinea:
Dr. Giuliana Proietti - Tel. 347 0375949
Dr. Walter La Gatta - Tel. 348 3314908
Costo della Terapia online, Individuale e di Coppia, 70 euro
Jung e la sincronicità Tra i concetti più affascinanti e dibattuti elaborati da Jung c’è quello della...
Il disturbo ossessivo-compulsivo (e test di automonitoraggio) Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) è un disturbo psicologico caratterizzato da...
Fare bei sogni Il mondo dei sogni è un territorio misterioso e affascinante che esploriamo ogni notte...
DOPO LA CRISI: COME SALVARE UN RAPPORTO DI COPPIA La vita di coppia è un viaggio appassionante,...