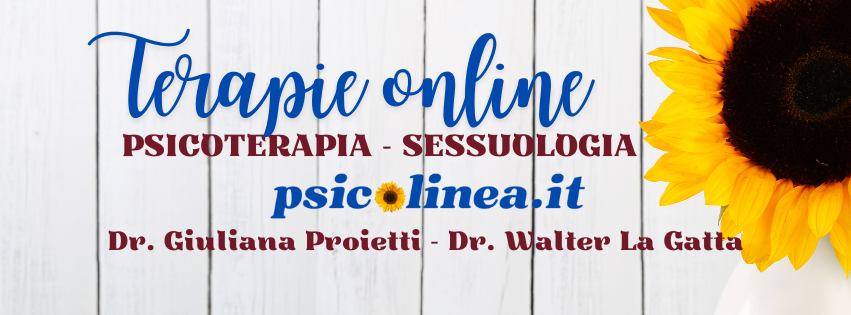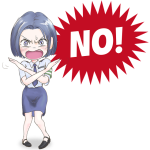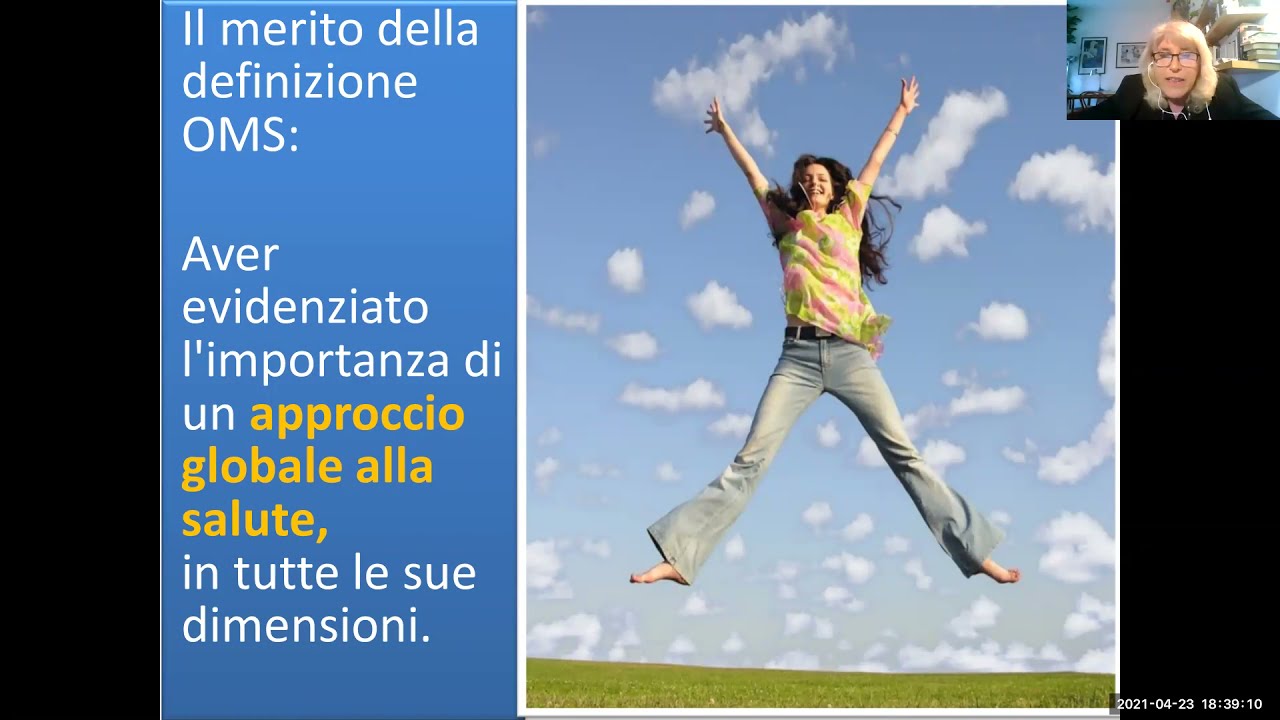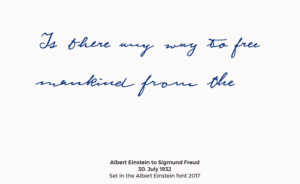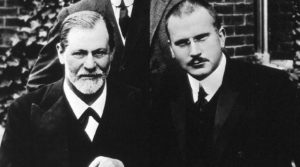Caterina da Siena: una biografia
Caterina Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena, Dottore della Chiesa, è, insieme a Francesco d’Assisi, la santa patrona d’Italia e la patrona delle infermiere. Giovanni Paolo II l’ha però definita anche “messaggera di pace” e “mistica della politica”, per il suo costante e convinto impegno a favore della pace.
A29
Caterina fu una donna molto forte, anche se con problematiche psicologiche importanti: era infatti anoressica e afflitta da perenni sensi di colpa. Nacque a Siena il 25 marzo 1347, nel cuore della contrada dell’Oca, figlia di Jacopo Benincasa, tintore, e di Lapa Piagenti, figlia del poeta Puccio il Piacente. Frutto della venticinquesima gravidanza di Lapa, nacque insieme alla gemella Giovanna, che morì quasi subito.
Fin da piccola Caterina frequentò i frati Predicatori e la basilica di San Domenico, vicina alla sua casa. A sei anni ebbe la prima visione: sospeso in aria, sopra il tetto della basilica di San Domenico, vi era Cristo, vestito con abiti pontificali, insieme ai santi Pietro, Paolo e Giovanni.
La madre di Caterina era una donna atea e anche lei molto forte e piena di energia (morì intorno ai cento anni: età incredibile per quell’epoca!), che non vedeva di buon occhio le scelte religiose piuttosto estreme della figlia.
Con lei Caterina infatti non andava d’accordo: la ragazza non si sentiva capita dalla madre e per questo, sin da bambina, aveva cominciato a cercare la forza interiore e l’affetto nella sua personale relazione con Dio.
Per capire il difficile rapporto tra madre e figlia possiamo affidarci alle parole della stessa Caterina: “Ho desiderato di un desiderio grande di vedervi madre vera, non solo del mio corpo, ma anche della mia anima. Penso che se voi amaste la mia anima più del mio corpo, ogni esagerata tenerezza in voi morrebbe e non soffrireste tanto di essere privata della mia presenza corporea. Al contrario ne trarreste consolazione, poiché, pensando che si tratta dell’onore di Dio, vorreste sopportare questa pena”.
A 15 anni Caterina perse la sorella cui era molto legata, Bonaventura, che morì di parto. Lapa decise allora che il genero, rimasto vedovo, si dovesse sposare con la giovane Caterina, anche per motivazioni economiche, dato che si trattava di un ricco tintore. La conflittualità con la madre in questo periodo fu intensissima, tanto che Caterina perse metà del suo peso. Il digiuno rappresentava la ferma opposizione verso un matrimonio che non voleva, dato anche il voto di castità che aveva fatto a Dio.
Costo della Terapia online, Individuale e di Coppia, 70 euro
Ma la rinuncia alla propria “corporeità” andava anche oltre: Caterina aveva infatti cominciato a seguire pratiche ascetiche, per cui si cibava di sole verdure, frutta e legumi crudi, che sputava dopo averli masticati per un po’. Se per caso non resisteva al desiderio di mangiare, poi si stuzzicava la gola con uno stelo di finocchio o con una piuma d’oca, fino a che non si sbarazzava del cibo inghiottito. A sedici anni, spinta da una visione di San Domenico, nonostante le resistenze della famiglia, vestì l’abito del Terz’Ordine di San Domenico, entrando a fare parte delle ‘Mantellate’, una sorta di suore laiche, che si dedicavano ad opere di carità e di preghiera. Caterina non scelse il convento e la clausura, perché il suo esclusivo rapporto con Dio non ammetteva regole, né interferenze.
La ragazza continuava così a vivere in casa, in una piccola cella, su un letto che aveva un cuscino di pietra. Di notte dormiva pochissimo, di giorno si flagellava, tra la rabbia e la disperazione della madre, che non la capiva. Di giorno Caterina andava a prestare servizio come infermiera volontaria al lebbrosario.
Un giorno, per punirsi del ribrezzo che le piaghe di un malato le suscitavano, bevve l’acqua che le era servita per lavare la ferita putrida, dichiarando poi che “non aveva gustato mai cibo o bevanda tanto dolce e squisita.” La stanchezza, il digiuno, la fatica, la portavano spesso ad avere delle visioni, delle estasi e degli svenimenti. A 21 anni Caterina perse il padre Jacopo, che lei stessa aveva assistito fino alla morte. Alla veglia funebre, nella convinzione che il padre avesse ormai raggiunto il Paradiso, ricevette i parenti sbigottiti con un sorriso di felicità impressa sul volto.
Pensava tuttavia di non fare abbastanza per rispondere a ciò che Cristo si aspettava da lei: i sensi di colpa continuavano a tormentarla, tanto che decise di non alimentarsi più, ed implorò Dio che le fosse concesso di “caricarsi sulle spalle gli errori e i mali della Chiesa e di coloro che la governano”.
Una Conferenza su Salute e Benessere
La notte di Carnevale del 1367 le apparve Cristo, accompagnato dalla Vergine e da una folla di santi, per donarle un anello, sposandola misticamente. Nel frattempo la sua fama andava espandendosi anche fuori della città di Siena ed attorno a lei cominciavano a raccogliersi dei fedeli. Preoccupati di tanto clamore, i domenicani vollero sottoporre Caterina ad un esame di ortodossia, che la ragazza superò brillantemente; l’ordine religioso le assegnò comunque un direttore spirituale, Raimondo da Capua, che divenne in seguito il suo erede spirituale.
Nel 1376 i fiorentini le chiesero di intercedere presso il Papa, con il quale c’erano stati motivi di disaccordo per motivi di tasse e di alleanze politiche. Caterina andò dunque come ambasciatrice di pace ad Avignone con alcune sue discepole, un altare portatile e tre confessori al seguito. Al papa Gregorio XI disse: “Otterrete di più col bastone della benignità che col bastone della guerra”. E fu così che il papa, convinto da Caterina, il 13 settembre 1376 lasciò definitivamente Avignone per fare rientro a Roma, come Caterina lo aveva implorato.
Il papa arrivò a Roma il 17 gennaio 1377, ma poco dopo morì. Naturalmente questa rientro comportò subito dopo un’aspra lotta fra papato e cardinali francesi, che volevano mantenere la corte papale in Francia. Di questo problema politico e diplomatico si occupò ancora Caterina, chiamata l’anno successivo a Roma dal successore di Gregorio XI, papa Urbano VI, per aiutarlo a risanare lo scisma occidentale che si era venuto a creare. Urbano VI era un papa con qualche squilibrio mentale, violento, ostinato; i Francesi però avevano nel frattempo eletto l’antipapa Clemente VII e la Chiesa romana, per sopravvivere, doveva essere difesa con una militanza energica, che Caterina generosamente elargì, malgrado le personali delusioni.
Il 29 aprile del 1380, tuttavia, a trentatré anni, Caterina cessò di vivere, stremata dalle mortificazioni ascetiche e dalla fatica.
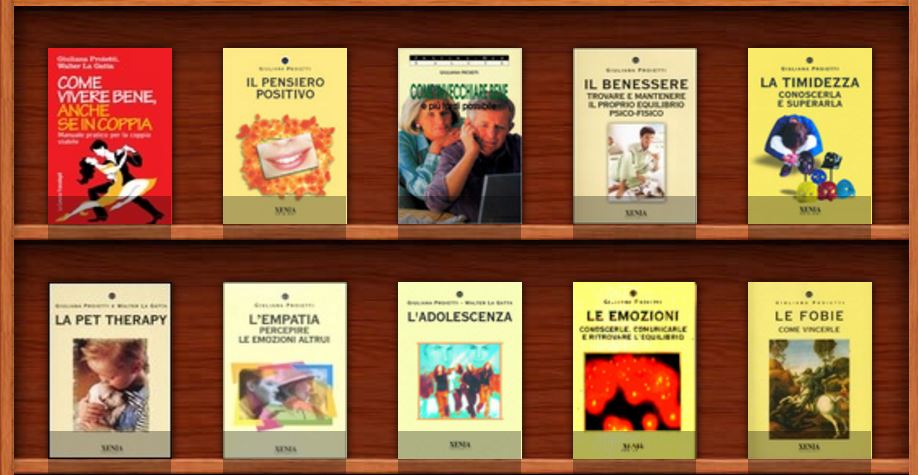 Autori:
Autori:
Dr. Giuliana Proietti - Dr. Walter La Gatta
Fu sepolta a Roma, nel cimitero di Santa Maria sopra Minerva, ma tre anni dopo le fu staccato il capo per portarlo, come reliquia, a Siena. Fu canonizzata il 29 giugno 1461, circa 80 anni dopo la sua morte.
Di lei ci rimangono delle attualissime lettere ai politici suoi contemporanei, nelle quali scriveva che la politica consiste nella buona amministrazione della cosa pubblica, al fine di ottenere il bene comune e non l’interesse personale. Il potere è solo un ‘prestito’ di Dio e dunque nessuno ha il diritto di appropriarsene indebitamente. Il buon amministratore dovrebbe prendere esempio da Cristo, che rappresenta l’ideale massimo della giustizia. Senza giustizia infatti, sentenziava Caterina, non c’è pace, e se manca la pace viene meno il presupposto che sta alla base della crescita sociale e morale di uno stato.
A Pietro del Monte, podestà di Siena, così scriveva: ‘Siate vero giudice e signore nello stato che Dio v’ha posto e direttamente rendiate il debito al povero ed al ricco, secondo che richiede la santa giustizia, la quale sia sempre condita con misericordia’.
Giuliana Proietti
PSICOTERAPIA SESSUOLOGIA ONLINE
Costo della Terapia online, Individuale e di Coppia, 70 euro
Anche su Instagram!
Psicolinea.it ©
Imm. Wikimedia, Brooklin Museum
20+ anni di Psicolinea:
oltre 2000 articoli di Psicologia e Sessuologia
Informazioni, Ispirazioni e Supporto
Psicolinea ti consiglia anche...
La relazione fra Sabina Spielr...
Ernesto Che Guevara e il fasci...
Consulenza - Dentro e Fuori di...
Come ci cambiano gli anni
Sigmund Freud e le sue donne
Consulenza online - Questioni ...

Dr. Giuliana Proietti
Psicoterapeuta Sessuologa
TERAPIE INDIVIDUALI E DI COPPIA
ONLINE
La Dottoressa Giuliana Proietti, Psicoterapeuta Sessuologa di Ancona, ha una vasta esperienza pluriennale nel trattamento di singoli e coppie. Lavora prevalentemente online.
- Delegata del Centro Italiano di Sessuologia per la Regione Umbria
- Membro del Comitato Scientifico della Federazione Italiana di Sessuologia.
Oltre che al lavoro clinico, ha dedicato la sua carriera professionale alla divulgazione del sapere psicologico e sessuologico nei diversi siti che cura online, nei libri pubblicati, e nelle iniziative pubbliche che organizza e a cui partecipa.
Per appuntamenti:
347 0375949 (anche whatsapp)
mail: g.proietti@psicolinea.it
Visita anche:
www.giulianaproietti.it